Nel 1865 Jules Verne, che può essere considerato uno dei fondatori della moderna fantascienza, pubblicava un romanzo intitolato “Dalla Terra alla Luna”, nel quale è descritto con un certo realismo un abitacolo a forma di proiettile sparato nello spazio, con a bordo un equipaggio umano.
Nel 1961 Jurij Gagarin, giovane talento dell’aviazione sovietica, veniva scagliato al di sopra dell’atmosfera nella navicella Vostok 1, diventando il primo cosmonauta della storia e trasformando in realtà ciò che per poco meno di cento anni era stato solo fantascienza.
Mentre si trovava in orbita, e per la prima volta occhi umani osservavano la Terra da una simile prospettiva, si narra che abbia detto: “La Terra è blu. Che meraviglia, è incredibile!”. E che abbia poi aggiunto: “Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini.”
Qualche volta le rivelazioni più sorprendenti sono allo stesso tempo le più ovvie. Questa storica frase in effetti, sotto un certo punto di vista, è proprio di un’ovvietà sconcertante. Che la Terra sia in gran parte coperta di oceani era un fatto già noto da tempo. Tutti inoltre sanno che in molti casi i confini tra gli stati sono convenzionali linee immaginarie, non visibili né da vicino né da lontano. Da un altro punto di vista, poi, l’affermazione è imprecisa, perché al contrario alcuni confini sono demarcati da evidenti discontinuità naturali come mari e catene montuose, ben visibili anche dallo spazio. Ciò nonostante questa frase suggerisce una verità fondamentale, che si stava consolidando non solo sotto gli occhi di Gagarin, ma anche di tutti i suoi contemporanei.
Se il concetto di “confine” poteva ancora avere una ragion d’essere nel diciannovesimo secolo, nel corso del ventesimo ha però a poco a poco mostrato una irreparabile obsolescenza. A causare questa obsolescenza, tra le altre cose, è stata proprio quella guerra fredda di cui Gagarin è stato protagonista, che ha portato alla situazione in cui gli eventi e le decisioni riguardanti un ristretto numero di Stati, e di un ristretto numero di persone all’interno di quegli Stati, possono condizionare pesantemente le sorti di tutto il pianeta, fino al punto di distruggerlo interamente. A questo si è aggiunta in anni più recenti una capillare diffusione di mezzi di comunicazione, che ha permesso virtualmente ad ogni individuo di entrare in contatto diretto con qualunque altro individuo al mondo, a prescindere dalla nazionalità.
Carl Sagan, scienziato e scrittore di fantascienza, rivolgendo lo sguardo verso la Terra da una distanza smisuratamente superiore a quella a cui era giunto Gagarin, ha inviato in tempi più recenti una sorta di messaggio dallo spazio che potrebbe essere visto come uno sviluppo delle parole del primo cosmonauta.
Noi però non ci fermeremo a questo sviluppo, per quanto nobile e suggestivo, ma ci impegneremo in una breve digressione di carattere storico che forse può aiutare a chiarire meglio i presupposti di questi messaggi piovuti dal cielo. Partiamo dalla ben nota, epocale ondata migratoria proveniente dall’Africa e diretta verso nord, che ha interessato vaste regioni del continente euroasiatico. Col passare del tempo molte di queste popolazioni da nomadi sono diventate stanziali e hanno iniziato a stabilire i confini dei loro territori, controllando e limitando il transito attraverso di essi. A partire da quel momento, e tanto più frequentemente quanto più aumentava la densità della popolazione, per migliaia di anni questi confini sono stati ripetutamente cancellati e ritracciati col sangue.
Alcuni di questi confini si trovano in quella che oggi chiamiamo Europa, e i discendenti di quei migranti partiti più di settantamila anni fa che oggi la abitano non si considerano più africani, ma appunto europei. Limitandoci anche solo agli ultimi 1000 anni di storia europea, vediamo che di tutto ciò che è stato fatto per controllare, difendere o espandere i confini non vi è molto di cui andare fieri.
Va aggiunto ancora che, non più tardi di quindicimila anni fa, dall’Eurasia la migrazione si è estesa anche a colonizzare il continente americano, dove ancora esistevano popolazioni nomadi quando dal sedicesimo secolo in poi ci fu un nuovo, massiccio esodo dall’Europa verso l’America. Non incontrando confini ben demarcati e adeguatamente difesi, questi europei non trovarono niente di meglio da fare che sterminare le popolazioni indigene, per poi tracciare, secondo le usanze delle madri patrie, nuovi confini su territori vergini, confini da difendere da nuove successive ondate migratorie come se il terreno da essi circoscritto fosse una proprietà privata assegnata per diritto divino. Ancora una volta, quindi, nulla di cui andare fieri.
Alla luce di queste considerazioni, il confine potrebbe essere inteso come il simbolo dell’incapacità umana di convivere pacificamente. In teoria esso dovrebbe tutelare la sicurezza e la stabilità delle nazioni, ma la storia mostra che questa sicurezza e questa stabilità sono del tutto illusorie.
Quella giunta dalla Vostok 1 è d’altronde una verità che è stata tramandata da tempo in espressioni e detti popolari come “tutto il mondo è paese” (come provato ad esempio da un’altra storica frase pronunciata da un famoso connazionale di Gagarin) o “siamo tutti sulla stessa barca”. Questo “tutti” individua quasi otto miliardi di esseri umani che condividono uno stesso piccolo pianeta, assieme ad un corredo non trascurabile –anzi essenziale– di milioni di specie viventi. Quando si è così tanti in uno spazio così ridotto, inevitabilmente i problemi di ciascuno diventano, almeno su lungo termine, problemi di tutti. E senza dubbio il problema più grande che questi abitanti del pianeta Terra hanno di fronte è lo squilibrio nell’accesso alle risorse essenziali per il sostentamento.
Se è comprensibile e forse inevitabile che il singolo individuo possa occasionalmente rivolgersi ad un suo simile con un’espressione come “che cazzo me ne frega di te, stammi lontano!”, e agisca di conseguenza, è ben più grave che in molte parti del pianeta stiano dominando o si stiano rafforzando correnti politiche che si concentrano sulla difesa del “confine”, credendo o facendo credere che rafforzare la propria identità nazionale nei confronti di ciò che sta fuori da tale confine, e difendendola fisicamente, con apposite barriere, dal contatto con i popoli stranieri, possa essere una scelta valida e lungimirante. Alla luce di quanto detto poc’anzi, naturalmente, poche idee potrebbero essere più miopi e stupide di questa. D’altra parte il limite delle moderne democrazie è proprio il rischio che i governanti riflettano i peggiori difetti del loro elettorato, tacendo poi il fatto che non pochi dittatori sono saliti al potere con il plauso o addirittura con il contributo diretto della popolazione.
Al momento l’unico vero confine è proprio quello che Gagarin quel giorno aveva superato, l’unico vero confine è il cielo. E lo sarà almeno finché un’altra ricorrente profezia della fantascienza non sarà avverata, cioè fino a quando non sarà possibile emigrare in massa in colonie extraterrestri. C’è chi ci sta lavorando con serietà e impegno, ma questa volta ci vorranno senz’altro più di cento anni perché sia realizzata. Che altre strade potremmo percorrere?
I lettori di Bue punto zero qualche anno fa hanno già incontrato una situazione in cui la soluzione ai problemi dell’umanità veniva cercata nella letteratura fantascientifica. Torniamo dunque sull’argomento scegliendo, tra i tanti che potrebbero essere citati, un racconto scritto da un’altra colonna della fantascienza, proveniente da un villaggio situato poco lontano da quello che diede i natali a Gagarin, e solo di pochi anni più anziano. Era da poco terminato un conflitto che aveva mietuto decine di milioni di vite umane, quando Isaac Asimov pubblicava un racconto dal titolo particolarmente significativo: “Conflitto evitabile” (The Evitable Conflict, 1950). Esso narra di un futuro non troppo lontano in cui quasi tutti i confini sono stati cancellati, riducendo la geografia politica a sole quattro Regioni, e in cui la pace e la stabilità sono garantite dalla trascendente intelligenza di “macchine” capaci di gestire le risorse economiche (e di conseguenza le decisioni politiche) dell’intero pianeta tenendo conto di un insieme smisurato di variabili, inclusa la tendenza degli uomini a disobbedire alle indicazioni impartite dalle macchine stesse, relegando il ruolo dei “coordinatori” umani a quello di semplice spettatore.
L’intelligenza artificiale era fantascienza fino a qualche decina di anni fa, ma oramai sta entrando prepotentemente nella vita di tutti i giorni, spesso senza che la gente lo sappia. È vero che molti potrebbero essere pronti ad accettare l’introduzione di simili soluzioni in molti campi, ma pretenderebbero che la politica rimanesse un’attività di esclusiva competenza degli esseri umani. Come è vero che la fantascienza ha anche descritto scenari apocalittici in cui queste “macchine” creano più problemi di quanti riescano a risolverne.
Tuttavia, quando fossero maturi i tempi, forse un tentativo potrebbe essere auspicabile. Senza bisogno di aiuti esterni, siamo riusciti a combattere due guerre mondiali e a sfiorarne una terza. La nostra occasione l’abbiamo avuta, e abbiamo giocato le nostre carte nel modo peggiore. Forse varrebbe la pena di dare un’opportunità anche alle “macchine”. Forse, nonostante tutto, potrebbe essere preferibile l’intelligenza artificiale alla stupidità umana.
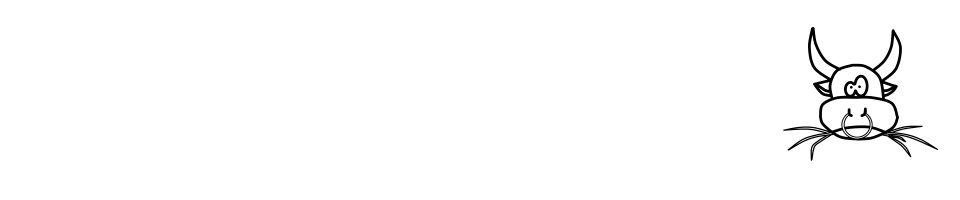


gattomannaro
/ 13 giugno 2018Caro Bue, poiché mi conosci da moltissimo tempo, sai che tendo ogni tanto a parlare per frasi d’opera e il tuo incipit mi ha richiamato irresistibilmente alla memoria Attila: “Oltre quel limite ti attendo o spettro”… soprattutto per l’idea dello spettro che ci minaccia tutti. Duplice spettro: da un lato l’ignoranza (voluta ed incoraggiata dai potenti) della storia, remota e recente, della specie umana e delle sue innumerevoli e spesso disastrose manifestazioni; dall’altro la tendenza a gettare nella più vicina pattumiera quello che forse è il solo valore fondamentale acquisito finora da questa specie feroce e predatrice: il concetto di “prossimo”, che non è necessariamente patrimonio di una religione, ma dovrebbe essere ciò che, nel corso dell’evoluzione, ci distingue dalle altre specie animali, che legano la loro sopravvivenza alle necessità della catena alimentare (ma, a dire il vero, solo in rari casi attaccato individui della loro stessa specie, come facciamo noi umani).
Penso l’interrogativo che tu proponi abbia solo una funzione retorica e provocatoria. Perché è proprio la “compassione”, non la razionalità – nell’uomo spesso drammaticamente carente – che ci distingue dalle macchine. La razionalità potrebbe salvarci dall’autodistruzione, ma l’attenzione all’altro è ciò che contraddistingue – almeno io la vedo così – l’evoluzione della nostra specie. Credo che siamo di fronte a un fenomeno epocale, una migrazione paragonabile a quelle che hanno foggiato l’umanità come la conosciamo oggi. Come andrà a finire, non lo so, e certo nessuno di noi vivrà abbastanza per saperlo. So che – a torto o a ragione da un punto di vista storico universale – voglio salvaguardare quello che mi sembra il più alto valore finora acquisito. E’ tanto barbaro quanto inutile armarci di scure e attendere gli “invasori” al riparo dei merli delle nostre torri. Ed è tanto barbaro quando profondamente sbagliato ritenere che il nostro pianeta non abbia risorse per mantenerci tutti. Il problema delle risorse è solo la loro distribuzione ineguale e il loro utilizzo dissennato. Un’intelligenza artificiale saprebbe fare meglio? Probabilmente… se avesse anche rispetto per l’individualità di ciascuno di quegli 8 miliardi di esseri umani che dovrebbero avere tutti lo stesso identico valore.
"Mi piace""Mi piace"
Bue punto zero
/ 13 giugno 2018Possiamo tutti concordare sul fatto che gli esseri umani hanno dei limiti. Forse molti possono concordare anche su un concetto che ho cercato di esprimere qui sopra, e cioè che per i problemi globali, le soluzioni locali non sono sufficienti. Ora, può darsi che la capacità di auto-organizzazione umana abbia incontrato il suo limite nella gestione di problemi globali che interessano un intero pianeta, la sua popolazione, la sua biosfera, il suo clima, eccetera. D’altra parte molti limiti umani sono stati superati dalle macchine da essi costruite. Nell’articolo ho usato il termine “trascendente” per sintetizzare questo passo del racconto: “un’intera équipe di matematici impiega parecchi anni di lavoro per mettere a punto un cervello positronico capace di eseguire i calcoli più complessi concepibili da un uomo. Poi si servono di quel cervello per elaborare calcoli ancora più complessi che servono a mettere a punto un cervello ancora più sofisticato del primo. E così via. Quelle che chiamiamo Macchine sono il risultato di dieci operazioni di questo tipo.”
Un processo del genere credo sia già iniziato, e salvo cataclismi probabilmente andrà avanti fino al punto in cui non avrà più senso chiedersi che cosa possiamo farcene delle macchine, ma saranno loro a chiedersi che cosa farsene di noi. Questo non è necessariamente un male (può anche darsi che esse sviluppino un concetto di “compassione” che supera e trascende il nostro. Il racconto in effetti presenta la situazione in maniera piuttosto positiva), ma se comunque tutto ciò è inevitabile, meglio iniziare ad abituarci all’idea.
Quindi, per concludere, qui sopra c’è sicuramente un intento provocatorio, ma anche una certa dose di pragmatismo e forse addirittura una vena di ottimismo.
"Mi piace""Mi piace"