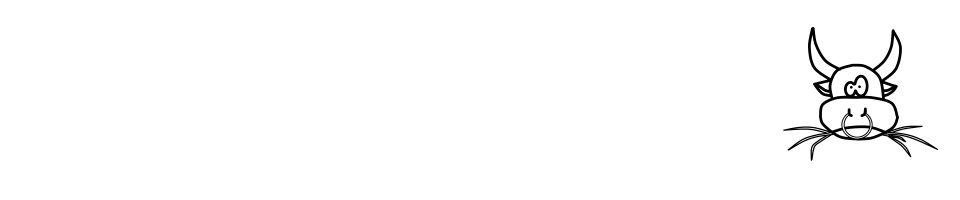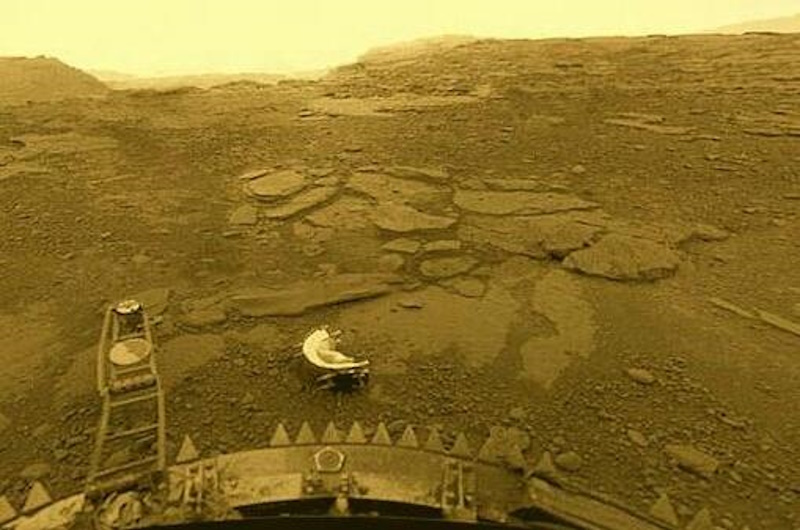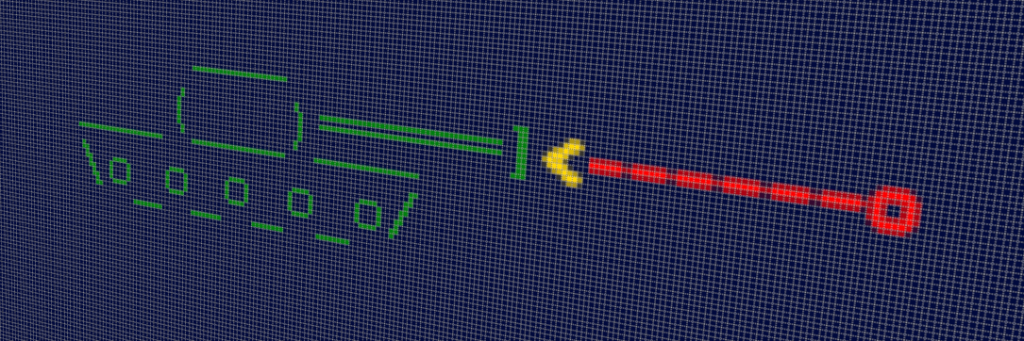
Se mi chiedessero qual è la mia parabola evangelica preferita, sarei sulle prime tentato di sceglierne una tra quelle più apertamente paradossali: quelle che, all’interno di una situazione tratta dalla vita quotidiana, propongono uno sviluppo del tutto controintuitivo e inatteso, incompatibile con ogni comune logica umana. Alla fine probabilmente però ne indicherei una che si trova esattamente agli antipodi, e per la precisione questa:
Un uomo aveva due figli; si rivolse al primo e disse: “Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna”. Rispose: “Non voglio”; dopo però, pentitosi, andò. Il padre si rivolse al secondo e disse allo stesso modo. Ed egli rispose: “Vado”; ma non andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?
Qui non si trova proprio nulla di paradossale; al contrario la risposta alla domanda è del tutto ovvia e scontata. Per chi non conoscesse il significato del termine “tautologia”, ne è un esempio lampante proprio questa frase: Il figlio che ha compiuto la volontà del padre è quello che ha fatto ciò che il padre gli ha ordinato.
Che senso ha quindi proporre una parabola tautologica, la risposta alla cui domanda conclusiva è elementare e non dice nulla in più del suo presupposto?
La soluzione del dilemma è semplice: la parabola fa ricorso a poche semplici parole per sbattere brutalmente in faccia agli ipocriti — in primo luogo a quelli che detengono posizioni di potere — la loro ipocrisia nella sua forma più nuda e spudorata; è evidente che l’efficacia del risultato è tanto maggiore quanto più la forma della parabola che lo persegue è elementare e disarmante.
Se ai tempi di Gesù l’ipocrisia era così diffusa e radicata da meritare il primo posto nella lista dei nemici del Regno di Dio, va detto che oggi non siamo messi meglio. Basta prendere in considerazione la classe politica, che è, almeno in uno stato democratico, espressione altamente rappresentativa della popolazione che vota per essa.
Se vi capita di ascoltare il discorso di un personaggio politico e sentirgli dire cose che vi suonano un po’ strane, vi propongo un esperimento: provate a sostituire alcune parti del discorso con il loro opposto. Supponiamo che il politico in questione ad un certo punto dica: “è in cima alle nostre priorità”; provate a sostituire queste parole con: “non ce ne frega assolutamente nulla”. Può darsi che il risultato appaia molto più convincente. Come il secondo dei due figli nella parabola, costui sta dicendo una cosa, mentre il suo pensiero e le sue azioni concrete si trovano all’esatto opposto.
Il problema è che non tutti si accorgono delle stonature nei discorsi dei politici, e non tutti quindi possono effettuare le dovute sostituzioni, rendersi conto dell’ipocrisia sottostante ed evitare l’inganno. Una delle manifestazioni più eclatanti e più disastrose dei danni provocati dall’ipocrisia dei politici si ha quando essi fanno leva sui sentimenti nazionalistici della popolazione: si tratta di una delle vie più facili per convincere le moltitudini ad agire contro i propri interessi e a favore degli interessi di pochi, facendo credere loro che stanno in realtà agendo per il bene della propria nazione. Il significato di questa locuzione è però in gran parte indeterminato, perché molto sfumati e ambigui sono i significati dei singoli termini che la compongono (“bene”, “propria”, “nazione”). La “mia” nazione è quella dove sono nato, oppure quella dove sono cresciuto, oppure quella dove vivo, oppure quella dove lavoro? Se la “mia” nazione è stata invasa e conquistata da un’altra, quest’ultima ne ha preso il posto, e sono tenuto ora a perseguire il suo “bene”? Se la “mia” nazione prepara una campagna bellica suicida, faccio il suo “bene” sostenendola oppure opponendomi ad essa? Eccetera.
Eppure sono tantissimi, in tutto il mondo, che si lasciano abbindolare da questo ingannevole ideale di nazione e si sacrificano per esso. In Germania si usa il termine unbedingt, che letteralmente significa “incondizionato”, “assoluto”, “senza compromessi”, per indicare una simile cieca adesione: un utilizzo particolarmente significativo di questo vocabolo è Generation des Unbedingten, espressione con cui si indica la generazione nata indicativamente nei primi anni del ventesimo secolo e che ha più di ogni altra contribuito a sostenere e rafforzare il regime nazista. Un modo particolarmente sinistro per renderla in italiano è: la generazione dei privi di dubbi.
A questo proposito mi piace ricordare la storia di un giovane poeta tedesco che ai tempi della Grande Guerra con versi intrisi di nazionalismo si adoperava per esaltare le imprese militari della sua patria; pieno di entusiasmo andò a prestare servizio al fronte come infermiere: gli bastò un mese a contatto con i corpi dilaniati dei suoi commilitoni per invertire drasticamente la propria strada e ritrovarsi, pochi anni dopo, a fuggire in esilio per sottrarsi ad un’accusa di alto tradimento, mentre le sue opere venivano messe al rogo dai nazisti.
Durante gli anni dell’esilio questo poeta, oltre ad affermarsi come uno dei maggiori drammaturghi del ventesimo secolo, compose una certa quantità di brevi poesie attorno al tema della guerra, delle quali riporto un paio di esempi:
Quelli che stanno in alto
si sono riuniti in una stanza.
Uomo della strada
lascia ogni speranza.
I governi
firmano patti di non aggressione.
Uomo qualsiasi,
firma il tuo testamento.
Quando chi sta in alto parla di pace
la gente comune sa
che ci sarà la guerra.
Quando chi sta in alto maledice la guerra
le cartoline precetto sono già compilate.
Se vi pare di cogliere un nesso con quanto detto poco sopra circa l’ipocrisia dei politici, vi assicuro che l’accostamento è voluto. Si vede proprio che dai tempi di Gesù fino ai tempi di Brecht, la situazione nel suo complesso non era cambiata di molto.
Concludo riportando ancora un’ultima breve poesia, che come la parabola dei due fratelli può sembrare a prima vista sorprendentemente banale, tanto semplici sono le parole, tanto ovvie sono le argomentazioni proposte: quasi una tautologia. La quale però, analogamente a quanto accade con la parabola, scolpisce nella pietra un messaggio che mette a nudo la miopia e la vacuità degli Unbedingten di ogni tempo.
La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
C’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
Faceva la fame. Fra i vincitori
Faceva la fame la povera gente egualmente.
(1939)
Leggi anche: