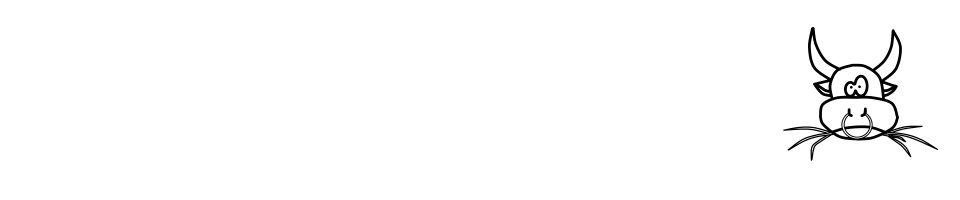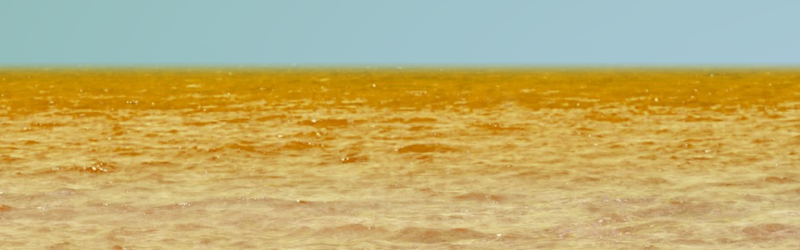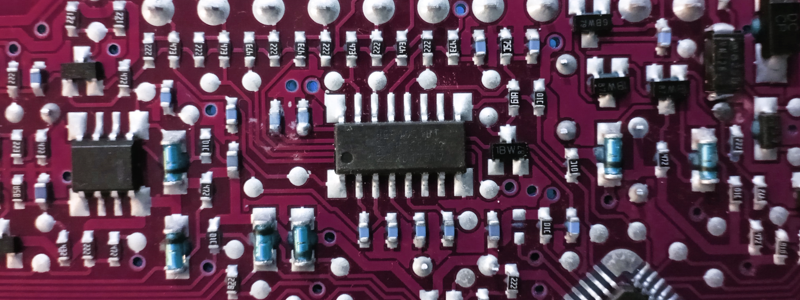Un paio di anni fa ai lettori di Bue punto zero è stata proposta l’affermazione secondo cui il problema più grande che gli abitanti del pianeta Terra hanno di fronte è lo squilibrio nell’accesso alle risorse essenziali per il sostentamento. Questa ardita proposizione era stata debolmente sostenuta con un riferimento alle esternazioni del World Economic Forum, la cui opinione in generale immagino non interessi a nessuno. Mi aspetto invece che, nel caso medio, la reazione all’affermazione proposta sia: può essere, ma –ammesso che ce ne siano– i problemi riguardano solo quelli che stanno dalla parte sbagliata dello squilibrio, quindi chissenefrega.
Qualcuno un po’ più illuminato potrebbe paventare tumulti, rivolte, conflitti, atti terroristici, migrazioni di massa, che a lungo andare estenderebbero il loro impatto anche su chi si trova dalla “parte giusta”. Questa eventualità per quanto realistica non rende giustizia alla complessità e alla gravità della situazione, e per questo vorrei ora argomentare l’affermazione iniziale affrontandola non genericamente da un punto di vista etico o sociale, ma da un punto di vista molto più specifico: quello ecologico.
L’ecologia ha alcune regole piuttosto rigide, e una di queste stabilisce che, quando la disponibilità di risorse non può crescere con lo stesso tasso con cui cresce la popolazione che le consuma, è indispensabile gestire tali risorse con la massima attenzione e utilizzarle con la massima parsimonia.
Prendiamo prima in considerazione quelle poche centinaia di persone smodatamente ricche che possiedono complessivamente l’equivalente del totale dei beni disponibili ai quattro o cinque miliardi più poveri. Possiamo immaginare che tra questi siano in pochi a condurre abitualmente una vita frugale, e che la maggior parte sia invece avvezza a consumare senza ritegno ogni genere di risorsa. Se anche qualcuno di essi contemplasse la possibilità che una data risorsa inizi prima o poi a scarseggiare, riposerebbe comunque sulla convinzione che, per quanto il suo prezzo possa crescere, potrà sempre permettersene a sufficienza per le proprie esigenze.
Prendiamo ora in considerazione chi si trova all’estremo opposto. Si tratta di un caso particolarmente interessante, perché la povertà genera paradossi, e i paradossi, con la loro capacità unica di stimolare le funzioni cognitive, sono un ineguagliabile strumento di conoscenza e di progresso intellettuale. Per capire che cosa intendo quando parlo di paradossi, prendiamo un caso tipico e ben noto: in molte aree del pianeta sono statisticamente più soggette al problema dell’obesità le fasce economicamente più svantaggiate rispetto a quelle benestanti. La spiegazione del fenomeno è semplice (chi ha più disponibilità economica ha la possibilità di nutrirsi in modo più sano e più opportunità di praticare sport e attività fisica), ma il risultato sulle prime può apparire contrario al comune buon senso.
Questo primo esempio è significativo, ma non riguarda direttamente l’ecologia. Il caso che ci interessa è quello di una singola famiglia o di un’intera popolazione che si trova a basare la propria sopravvivenza su un’unica fonte di sostentamento, cosa che capita comunemente nelle realtà più povere del pianeta. Si tratta di famiglie o popolazioni a cui il concetto di “pane quotidiano” è estraneo non tanto perché il pane non fa parte della loro cultura gastronomica, ma perché la disponibilità di cibo è discontinua e occasionale. La fonte di sostentamento a cui attingere potrebbe consistere ad esempio in un piccolo appezzamento di terreno coltivabile, o nella fauna ittica che abita un fiume. Al crescere del numero di bocche da sfamare, questa risorsa sarà sfruttata in modo sempre più intensivo, aumentando via via il rischio di esaurirla: un terreno coltivato a cui non si lascia periodicamente un anno di riposo può infatti perdere la sua fertilità; la popolazione di pesci, indiscriminatamente decimata, può non riuscire a rigenerarsi abbastanza rapidamente da compensare la perdita. Il paradosso qui sta nel fatto che queste persone, la cui sopravvivenza dipende interamente da una singola risorsa, e che quindi sono le prime ad avere interesse alla sua conservazione, sono causa diretta, e spesso tragicamente consapevole, della sua distruzione. Avrebbero un vantaggio immediato e sostanziale a vivere in modo ecologicamente sostenibile, ma semplicemente non possono permetterselo.
A questo punto non resta che tirare le somme. Un grande e crescente squilibrio nella ripartizione delle risorse comporta che ci sia da un lato un piccolo numero di persone che ne possiedono un’enorme quantità e che, vivendo nell’illusione che siano inesauribili, sono propense più a dissiparle che a preservarle; dall’altro lato un enorme numero di persone che dispongono ciascuna di una piccola risorsa la quale viene spesso sfruttata fino all’esaurimento. Comporta inoltre che la “zona grigia” intermedia, comprendente coloro che ragionevolmente potrebbero assumere in modo consapevole ed efficace comportamenti virtuosi in accordo con la regola enunciata all’inizio di questo discorso, si assottigli sempre di più. Il risultato netto è un impoverimento globale delle già scarse risorse del pianeta, tanto più rapido e drastico quanto più sono accentuate le disuguaglianze. E non c’è dubbio sul fatto che questa conseguenza riguardi tutti, anche coloro che non possono o non vogliono trarla.
Ovviamente non ci sono soluzioni semplici a problemi di questa portata (a parte forse questa). Però qualche idea può venire fuori. Iniziamo, a scopo simbolico più che pratico, dal vertice della piramide. In base alle statistiche correnti, pare che l’uomo più ricco del mondo sia tale Jeffrey Preston Bezos (per dare un’idea, l’un percento dei suoi averi equivale alla spesa sanitaria annuale dell’intera Etiopia). Anche qui ci troviamo di fronte ad un gustosissimo paradosso: ci sono molte decine di milioni di persone –tutte ovviamente molto meno ricche di lui– che deliberatamente aumentano il già smisurato divario versando un obolo periodico al nostro campione. Tra l’altro, con lo scopo primario di agevolare l’acquisto compulsivo di merce in gran parte inutile, con ulteriore ingiustificato depauperamento delle risorse planetarie. Con ciò non voglio dire che si debbano boicottare le sue attività, né che si tratti di una cattiva persona. Al contrario, risulta che abbia al suo attivo iniziative filantropiche e un serio programma di viaggi spaziali. Ma come ho detto all’inizio, qui non si tratta semplicemente di questioni etiche, quindi questi aspetti sono essenzialmente irrilevanti. Ciò che interessa è proporre un esempio-simbolo di come ciascuno possa avere la sua parte nel contribuire deliberatamente –o viceversa nell’opporsi– ad un progressivo aumento delle disparità economiche.
Un altro esempio utile lo si trova scorrendo brevemente la classifica e soffermandosi al quinto posto, dove è attualmente posizionato Mark Elliot Zuckerberg. A quanto pare buona parte della sua fortuna gli arriva dalla spontanea elargizione di inserzionisti i cui messaggi pubblicitari vengono quotidianamente visualizzati, in mezzo ad un mare di altre cazzate, da miliardi di persone. Anche in questo caso, non intendo proporre come ricetta il boicottaggio, ma piuttosto un utilizzo responsabile. Facebook potrebbe essere usato meno per le cazzate e più per diffondere articoli che stimolano riflessioni costruttive sul destino del mondo.