L’argomento di questo articolo è il lockdown programmato come soluzione permanente alla crisi sanitaria in atto. Permettetemi però una breve premessa.
Forse avrete già capito che sono contrario all’abuso di anglicismi, da cui la lingua italiana è ogni giorno più contaminata. Ciò non significa ovviamente che io disprezzi la lingua inglese o la sua letteratura, tutt’altro. Giusto poco tempo fa l’intervento del virus, a cui ho dato spazio su queste pagine, con i suoi richiami alle estinzioni di massa mi ha fatto ripensare ad un suggestivo sonetto di Shelley: Ozymandias. Se non lo conoscete, potete trovarlo qui (una traduzione è disponibile in fondo all’articolo nella sezione dei commenti). L’argomento è il crollo di un antico, potente impero e del suo superbo sovrano; al viandante attonito non resta ora da ammirare altro che qualche frammento di un’enorme statua in mezzo al deserto. Sul piedistallo, se non ricordo male, si possono ancora leggere le parole: “Andrà tutto bene”.
Tornando agli anglicismi, devo ammettere che a volte anch’io mi arrendo. Quando uno di essi entra nell’uso quotidiano, a meno che non sia proprio orripilante, può essere che anch’io finisca per utilizzarlo. Ad esempio la parola “lockdown” è passabile: ha un che di cupo e opprimente che le permette di trasmettere in modo particolarmente efficace il proprio significato. Per questo ora parlerò finalmente di lockdown.
Se affermassi che il montare della seconda ondata era ampiamente previsto, e che in molti Paesi del mondo le autorità non hanno fatto abbastanza per arginarla (coprendosi di ancora maggiore vergogna rispetto alla prima), probabilmente direi una banalità. Così come è ormai un luogo comune constatare che dovremo convivere a lungo con questo virus. Pure è per tutti ovvio che il problema principale è contemperare le esigenze di tutela della salute con quelle delle attività economiche. È piuttosto evidente anche che la vera minaccia per l’economia non è tanto il lockdown in sé, ma l’incertezza sul futuro e il continuo mutare delle regole e delle restrizioni.
Se tutte queste cose sono così chiare, però, forse a molti non lo è la conseguenza che se ne deve trarre. Quello che serve davvero sono i lockdown programmati. Come ipotesi, immaginiamo di stabilire (a livello il più possibile sovranazionale) che ogni tre mesi ci si ferma per uno. Nei tre mesi di attività la curva dei contagi inevitabilmente cresce, ma il mese di sosta permette di alleggerire il carico sul sistema sanitario e ripartire poi da una situazione più gestibile. Tutte le attività economiche (inclusi lo sport e lo spettacolo, ma anche scuola, università e simili) possono però essere pianificate in maniera efficiente tenendo conto di un calendario prefissato, e il margine di incertezza si riduce drasticamente: le aziende invece di restare congelate dal timore di compiere un passo falso e buttare via il poco capitale rimasto possono programmare i propri investimenti con la ragionevole certezza di un rientro. Naturalmente i beni e i servizi che non possono essere utilizzati nel mese di chiusura subiranno un aumento fisiologico del prezzo negli altri periodi: è lo scotto da pagare per tenere in piedi l’economia ed evitare che gli esercizi commerciali e le imprese danneggiati dalla chiusura forzata vadano in bancarotta. Parallelamente però gli Stati dovrebbero compiere ogni sforzo per moderare il costo di tutti i beni e servizi che al contrario sono maggiormente utilizzati a causa dell’emergenza, garantendone così l’accesso a tutti ed evitando che ci siano attività che ne beneficiano in maniera eccessiva, arricchendosi alle spalle di chi è in sofferenza a causa della crisi.
Una volta tanto mi fa piacere non essere il solo a pensare e a proporre certe soluzioni: a volte ci arrivano anche gli scienziati. Ad esempio in questo articolo su New Scientist (ovviamente in inglese) si riportano le parole di qualcuno che è dell’idea che non ci si debba perdere ogni volta in interminabili discussioni su come fronteggiare la pandemia, ma che si debbano attivare degli automatismi basati sui parametri del contagio. Nello stesso articolo si propone proprio l’ipotesi dei lockdown programmati. È normale che i ministri diano poco peso all’opinione di un bovino, ma forse se dessero un po’ retta almeno agli scienziati, qualche speranza l’avremmo. Invece finora ci si è limitati a reagire in maniera confusa e approssimativa, navigando a vista e, cosa ben grave, prendendo di volta in volta le decisioni su come muoversi sulla base di dove la nave si trovava dieci o venti giorni prima. I risultati di questa strategia, per ora, non sono incoraggianti. Forse sarebbe il caso di iniziare a valutare scelte un po’ più coraggiose e più avvedute.
Dopo il prossimo lockdown ci sarà una nuova alba. Il punto è se saremo lì a vederla, o se il sole illuminerà solo rovine abbandonate in uno sterminato deserto.
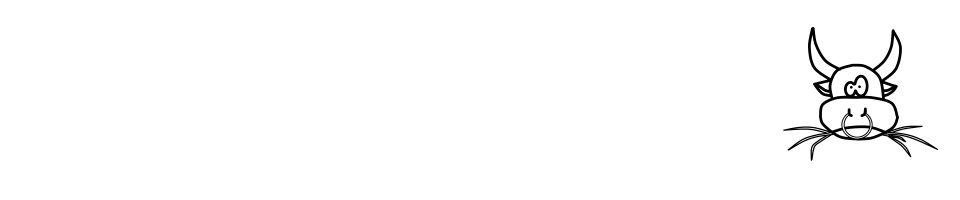


gattomannaro
/ 31 ottobre 2020Caro Bue, come certo sai, i gatti pensano e conoscono moltissime cose (o almeno riescono a dare questa impressione), ma si guardano bene dal comunicarle agli umani, che molto probabilmente ne farebbero pessimo uso. Essendo Mannaro, e perciò un po’ gatto e un po’ umano, non ho remore a proclamare la mia totale incompetenza e parlare dell’argomento Covid. Diversamente da molti – troppi – altri, so di non sapere e non parlo di cose che non so. A proposito, invece, della cose che so, ho trovato abominevole la traduzione italiana del bellissimo sonetto di Shelley (anche quello non lo conoscevo…) Confesso di non conoscere il traduttore, magari è uno famoso e stimatissimo, ma la traduzione rimane di una bruttezza unica, e in molti casi è anche inesatta rispetto al significato dei termini usati dal poeta. Perciò, se non ti dispiace, ho in mente di farne una mia e mandartela.Se poi la vorrai condividere con i tuoi lettori, la scelta è solo tua. Cari saluti!
"Mi piace""Mi piace"
Bue punto zero
/ 31 ottobre 2020La traduzione italiana del sonetto che si trova su Wikipedia a mio avviso soffre soprattutto della pretesa di mantenere le rime presenti nell’originale. La scelta di pubblicare quella traduzione probabilmente è stata dettata dal fatto che fosse libera da diritti, sicuramente esistono traduzioni migliori. A volte in passato ho proposto una mia versione di testi poetici in lingue straniere, ma questa volta ho lasciato perdere. Comunque metti pure la tua traduzione qui in un commento, la segnalerò nel testo. Grazie!
"Mi piace""Mi piace"
Yuri
/ 2 novembre 2020Io penso che non si siano mossi solo in maniera confusa, ma ancor peggio tenendo conto dell’impatto sull’opinione pubblica, addolcendo la pillola poco alla volta; altrimenti come giustifichi il bonus vacanze, tanto per dirne uno?
Non voglio dire che in Cina sono migliori di noi, perché ci sono condizioni che non solo ledono la privacy, ma anche le persone in modo neanche troppo indiretto. Però lì, se non sbaglio, hanno effettuato un numero ben più alto di tamponi per testare tutta (o quasi la popolazione) ed hanno attuato un lockdown iniziale volto a debellare la fetta più grande della pandemia, dopodiché hanno proceduto con dei lockdown puntuali nelle regioni dove veniva rilevato anche un solo positivo (testando in massa tutta la regione sottoposta a lockdown e tracciando in modi che nella cultura occidentale verrebbero sicuramente interpretati come una chiara ed evidente violazione della privacy). Magari sono notizie false, ma ad oggi la Cina è tornata alla normalità.
Noi invece, Testiamo poco, Tracciamo a caso e sforniamo DPCM dal valore discutibile, mandando però tutti in vacanza ad Agosto.. ah già… in monopattino… o su un banco con le rotelle…
"Mi piace""Mi piace"
Bue punto zero
/ 3 novembre 2020Grazie per il commento!
Per quanto riguarda il confronto con la Cina, sicuramente in una situazione come questa si fa sentire la differenza tra un regime monopartitico, quale è quello cinese, e le democrazie europee. Il primo e deprecabile per tanti motivi, ma ha almeno il vantaggio di non doversi fare troppi scrupoli a fare quello che va fatto.
Per il resto, non me la sento di criticare ogni singola scelta dei governi, che obiettivamente si sono trovati in una situazione molto difficile. Fra tante incertezze, però, ci sono alcuni punti fermi, che ho in parte cercato di evidenziare nell’articolo: primo, obiettivamente il sistema sanitario è stato posto sotto una pressione senza precedenti (basta chiedere a chi lavora negli ospedali o ai medici di base); secondo, la nuova ondata era una certezza matematica, e questa volta l’Italia ha seguito a ruota altri Paesi europei come ad esempio la Francia, e ha avuto uno strumento in più per prevedere gli sviluppi; terzo, il male peggiore per l’economia è l’incertezza sul futuro. Mettendo insieme tutte queste cose, ci stava che all’inizio di ottobre si proponesse anticipatamente di chiudere per una ventina di giorni a novembre. Il risultato sarebbe stato quasi lo stesso, con la differenza che tutti si sarebbero organizzati prima e meglio.
"Mi piace""Mi piace"
gattomannaro
/ 4 novembre 2020A gentile richiesta, e totalmente fuori tema, ecco la mia personale traduzione del sonetto di Shelley:
Ho incontrato un viaggiatore venuto da una terra antica
Che disse: Due enormi gambe di pietra senza tronco
sorgono nel deserto. Vicino, sulla sabbia,
mezzo sepolto, giace un viso spezzato, il cui cipiglio,
e il labbro corrugato, e il sogghigno di freddo comando
dicono che il suo scultore ben leggeva quelle passioni
che ancora sopravvivono, impresse su quelle cose morte,
alla mano che le ha ritratte e al cuore che le alimentava.
E sul piedestallo queste parole appaiono:
Il mio nome è Ozymandias, re dei re:
Guardate alle mie opere, voi Potenti, e disperate!”
Null’altro rimane. Intorno al disfacimento
del rudere colossale, sconfinate e nude
le sabbie solitarie e uniformi si stendono in lontananza
"Mi piace""Mi piace"
Bue punto zero
/ 4 novembre 2020Grazie, ottima traduzione, e niente affatto fuori tema!
"Mi piace""Mi piace"