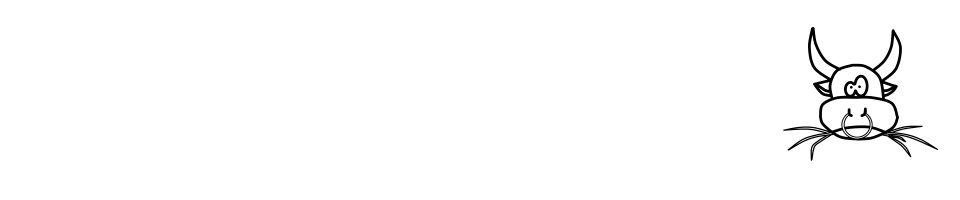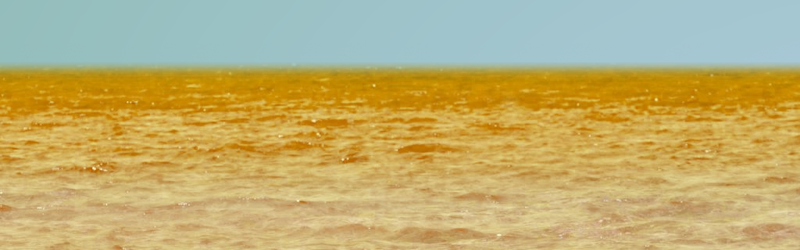
Un argomento trattato sporadicamente su queste pagine e che, per la sua intrinseca levità, è il caso di riprendere in questo spensierato periodo di vacanza, è la geopolitica globale.
Tra le lapalissiane tesi sostenute negli articoli precedenti abbiamo ad esempio:
È utile a proposito di quest’ultimo punto osservare che il tasso di crescita della popolazione tende ad essere esponenziale, mentre la disponibilità di molte risorse essenziali è in diminuzione. Per questo non dovrebbe sorprendere che parlando di problemi globali non abbia finora citato esplicitamente i cambiamenti climatici, che da anni sono sotto i riflettori e di cui sempre più persone stanno facendo esperienza diretta. Proprio questi fattori comportano il rischio di convincersi che tali cambiamenti siano il principale se non l’unico problema globale, con il catastrofico risultato di perdere di vista gli altri, e in particolare quelli relativi al punto 3. Il clima rappresenta certamente un tassello importante nel quadro complessivo, ma è un problema che non può essere affrontato senza la consapevolezza di tutti gli altri.
Per illustrare questo concetto mi servirò di un esempio, che non pretende di essere in sé particolarmente realistico, ma solo di suggerire un possibile approccio.
Partiamo dalla desertificazione, che è un problema abbastanza diffuso da poter essere a buon diritto considerato globale, e riguarda la disponibilità di terreno coltivabile. Per il nostro esempio scegliamo tra i tanti un caso specifico, quello dell’Eritrea (un altro Stato con problemi simili andrebbe altrettanto bene). Il suo territorio era un tempo coperto per circa il 30% da foreste; un’intensa e deliberata attività di deforestazione ha ridotto questo valore ad un misero 1%. Tale attività, e non il cambiamento climatico, è la causa diretta della desertificazione in atto nel Paese. Iniziative di riforestazione sono in corso, con obiettivi ambiziosi ma risorse disponibili ovviamente limitate.
Spostiamoci poi nell’Oceano Pacifico, dove si sperimenta un problema per certi versi opposto a quello della desertificazione: l’innalzamento dell’oceano dovuto allo scioglimento dei ghiacci polari minaccia di ridurre drasticamente l’estensione di alcune isole e di farne sparire completamente altre. Questa volta si tratta di un problema strettamente legato al riscaldamento globale, per il quale non c’è una soluzione diretta a breve termine (pur con tutta la buona volontà, potrebbero volerci secoli per un’inversione di tendenza). La risposta all’emergenza di governi come quello di Tuvalu, minuscolo Stato polinesiano, si limita pertanto alla proposta di ricreare l’ambiente delle isole sommerse in un universo digitale. In mancanza di meglio, si può ipotizzare che la popolazione delle isole non più abitabili si trasferirà nelle isole attigue, le quali con una superficie ridotta dovranno ospitare una maggiore pressione demografica, con inevitabile peggioramento della qualità della vita e nascita di potenziali conflitti e disordini. Mentre nel caso precedente la risorsa vitale in via di esaurimento è il terreno fertile, in questo caso tale risorsa è il semplice terreno calpestabile.
Ora possiamo supporre che una buona parte della popolazione polinesiana, presa dai suoi gravi problemi, non si interessi molto a ciò che accade in Eritrea, e magari non sappia neppure che cosa siano il deserto e la desertificazione; dall’altra parte neppure la popolazione eritrea potrebbe essere particolarmente interessata ai problemi di chi vive in mezzo all’oceano dall’altra parte del mondo. Riconoscere quelli descritti come problemi globali (cioè problemi che non riguardano solo due stati o due popoli, ma l’intero ecosistema planetario) però può permettere di connettere due situazioni critiche e convertirle in un’unica opportunità di sviluppo delle risorse globali. A monte di tutto dovrebbe collocarsi un organismo sovranazionale che raccoglie ed elabora informazioni dettagliate sulle risorse e sulle criticità di tutto il mondo, e propone soluzioni basate su questi dati. Data la smisurata complessità dei problemi, come suggerito nel racconto “Conflitto evitabile” — di cui si era parlato a suo tempo –, tale organismo potrebbe essere costituito, o almeno coadiuvato, da un’intelligenza artificiale.
Esaminando le problematiche introdotte sopra, questo ente potrebbe proporre di stanziare un ingente finanziamento mirato ad una drastica riforestazione dell’Eritrea. A mano a mano che si strappa terreno abitabile al deserto, la popolazione polinesiana a rischio viene invitata a trasferirsi su quel territorio, in modo che possa trovare un luogo dove vivere e allo stesso tempo offrire il proprio contributo ad un’ulteriore attività di bonifica e più in generale all’economia planetaria, che avrà bisogno di risorse per attivare progetti analoghi in altre parti del mondo.
Tra gli elementi di cui tener conto nella pianificazione di un simile intervento ci sono le reazioni delle popolazioni coinvolte. I polinesiani potrebbero non essere particolarmente propensi ad affrontare un cambiamento così radicale, ma una volta con i piedi a bagno in mancanza di alternative migliori probabilmente molti di loro accetterebbero. D’altra parte la popolazione eritrea potrebbe non vedere di buon occhio l’ingresso di decine di migliaia di stranieri nel suo territorio. E qui si arriva al punto cruciale: si è detto che la desertificazione è un problema molto diffuso, quindi se la riuscita del progetto fosse a priori minacciata da una conclamata indole intollerante della popolazione ospitante, la scelta del territorio da riforestare potrebbe cadere su qualche altro Stato — poniamo la Somalia — la cui popolazione si mostri più ospitale. Detto in altri termini: una popolazione nota per la sua intolleranza potrebbe perdere l’occasione di una riforestazione completa e gratuita.
Ho speso tempo in un esempio concreto per facilitare chi ha problemi con la capacità di astrazione, ma il concetto è abbastanza evidente di per sé: chi commette la leggerezza di mostrarsi intollerante rischia di essere considerato una zavorra nel momento in cui urge trovare disponibilità alla collaborazione per affrontare in maniera rapida ed efficace problemi globali, e come tale potrebbe essere senza troppi patemi abbandonato a se stesso. Se l’intolleranza poi non fosse caratteristica peculiare di un numero limitato di popolazioni, ma fosse diffusa capillarmente in tutto il mondo, il risultato sarebbe più semplicemente il fallimento di qualunque progetto di collaborazione analogo a quello descritto.
Tirando le somme, ne consegue che chi incita in qualunque modo e a qualunque titolo all’intolleranza si rende colpevole di un gravissimo crimine contro l’umanità, e chi tollera gli atteggiamenti intolleranti si rende complice dello stesso crimine.
Mostrarsi intolleranti nei confronti dell’intolleranza può sembrare incoerente o poco elegante, ma è già stato dimostrato da tempo che è l’unico atteggiamento compatibile con la necessità di preservare la società civile. Qui non si tratta di buona educazione, né di usare diplomazia per mantenere buoni rapporti di vicinato. Si tratta di evitare il collasso della civiltà umana. Quindi fate un po’ voi.