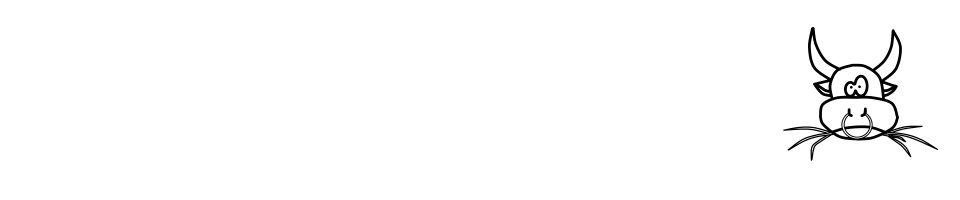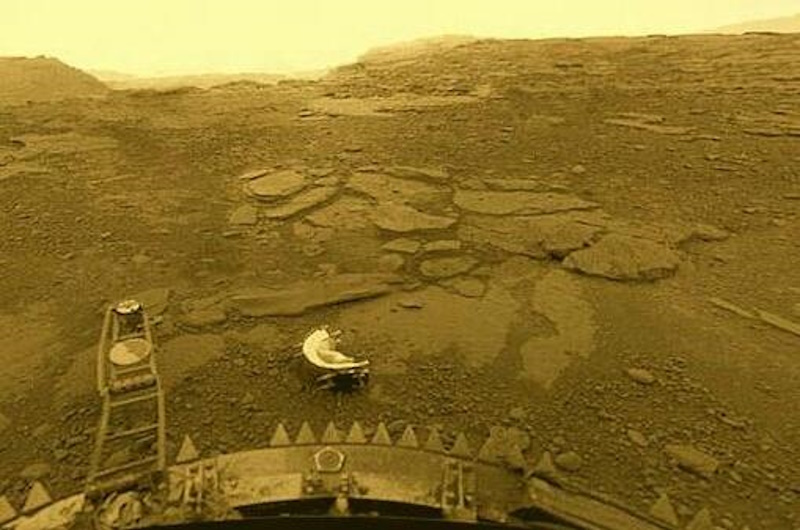Ai lettori che fossero rimasti traumatizzati dagli ultimi articoli pubblicati posso subito offrire una rassicurazione: questa volta si parla di cose gravi ma non serie. Essendo che tutto è connesso a tutto, comunque, troverete alla fine un legame con quanto precede.
Ho i miei buoni motivi per affrontare oggi una questione linguistica discutendo un paio di casi di degenerazione della lingua italiana che stanno progressivamente infestando i giornali e rischiano quindi di venire poi accolti a pieno titolo nei vocabolari.
Iniziamo dal verbo “postare”, che risulta attestato fin dal ‘500, utilizzato quasi esclusivamente in ambito militare e la cui origine e il cui significato sono analoghi al più comune “appostare”. Brutto finché volete, ma in questi secoli non ha arrecato grossi danni alla lingua italiana. Ora però la vera minaccia viene dal suo omofono beceramente derivato dall’inglese “to post”, verbo che al suo antico significato di “affiggere” aggiunge quello più moderno di “condividere su Internet”.
Ogni volta che qualcuno arbitrariamente applica il suffisso “-are” ad una qualunque parola inglese e inizia a coniugare il risultato come se fosse un verbo italiano si compie un piccolo scempio, ma l’uso del verbo “postare” nella nuova accezione (insieme ovviamente allo strettamente correlato sostantivo “post”) sta diventando così virulento che non si può più stare zitti a guardare senza fare niente.
Per prima cosa verrebbe spontaneo chiedersi che bisogno ci sia di inventarsi nuove parole quando quelle che già ci sono vanno benissimo, anzi suonano molto meglio e permettono di esprimere più sfumature. Invece di “postare un post” non si può con più eleganza dire “pubblicare un articolo” o “inviare un commento” o “esporre un pensiero” o “proporre un intervento” o “esibire al pubblico ludibrio la propria cazzata quotidiana”?
A parte l’intrinseca bruttezza, che — mi rendo conto — potrebbe anche derivare da una valutazione soggettiva, c’è poi il problema che questi due nuovi termini vanno ad occupare una nicchia fonetica già abbondantemente affollata, creando dei bisticci quasi esilaranti:
- con il sostantivo “posta” e derivati. Tutto ciò che concerne i post può essere definito “postale”? Un post molto breve è un “postino”?
- con il sostantivo “posto”: i post insulsi e spregevoli (e non sarà difficile trovarne) sono dei “postacci”?
- con il participio passato del verbo “porre”: “posto che il post è ormai postato, come possiamo rimediare?”
- con il prefisso post-, già di per sé un po’ troppo abusato: come difendersi da un post bellico? E che farsene di un post datato?
Dopo queste considerazioni, la seconda domanda da porre (e va posta adesso, non ai posteri) è: nella lingua italiana, “postare” ci può stare? O, in altre parole: c’è posto per “postare”?
Mentre pensate alla risposta, porto avanti un’altra riflessione. Lo sviluppo cognitivo umano segna le sue tappe fondamentali di pari passo con lo sviluppo del linguaggio. Nei primi mesi di vita i bambini iniziano a pronunciare alcune sillabe, spesso ripetendole più volte: “ma-ma”, “na-na”, “pa-pa”, “pi-pi”, “pot-pot”. Dopo qualche altro mese, possono progredire fino ad arrivare ad un’articolazione un po’ più complessa come “posto un post”. L’importante è non considerarlo un punto di arrivo, ma proseguire nello sviluppo in modo da arricchire ulteriormente le proprie capacità espressive.
Passo ora ad introdurre il secondo tema, forse più sottile ma a mio avviso ben più serio. Si tratta dell’abitudine via via più diffusa di utilizzare l’aggettivo italiano “severo” con gli stessi significati che la lingua inglese assegna all’aggettivo “severe”. Il percorso che ci porta a comprendere dove sta l’errore è piuttosto lungo, e inizia dal contesto. Nella lingua inglese esistono vocaboli come il verbo “to sever” (recidere, spezzare) e il suo participio “severed” (reciso, spezzato); il significato di questi vocaboli porta con sé un carico di sofferenza e di irreversibilità che un anglofono non può non aver presente, anche solo inconsciamente, quando sceglie di utilizzare l’aggettivo “severe”. Infatti esso ha in inglese sempre un’accezione negativa ed è usato comunemente per descrivere le conseguenze di un trauma, un incidente o una malattia; in questi casi il modo migliore per renderlo in italiano è quasi sempre “grave” o “pesante”.
Il contesto dell’aggettivo “severo” in italiano è completamente diverso, e lo testimonia il primo luogo il fatto che esso, assieme a varianti e derivati come Severiano o Severina, è usato come nome proprio di persona, e indica quindi delle qualità positive e auspicabili. Si potrebbe comunque pensare che i significati di “severo” e “grave” (il cui significato primario equivale a “pesante”, ma espresso con una maggiore intensità) siano in gran parte sovrapponibili, ma contro quest’idea intendo ora sollevare le mie obiezioni.
Tra i significati dell’italiano “severo”, iniziamo a considerare quello in virtù del quale si può dire che uno stile (di un’architettura, ad esempio, o di una scultura, o di un contrappunto musicale) è “severo”. In questo caso il significato da intendere è “asciutto”, “essenziale”, “sobrio”, “lineare”, “senza fronzoli”, da contrapporsi a “ridondante”, “sovraccarico”, “sfarzoso”, “barocco”. Non è quindi ciò che esprime severità, ma è il suo opposto a risultare appesantito, “gravato” da elementi aggiuntivi e superflui di cui lo stile severo fa volentieri a meno, risultando quindi in realtà più leggero.
Accostando poi a questo significato quello più comunemente inteso quando si parla ad esempio di un giudice severo o di un maestro severo, possiamo osservare un’altra importante differenza, che riflette quella ancor più fondamentale distinzione che la mente umana (e di conseguenza il linguaggio da essa sviluppato) opera sul mondo: quella tra cose e persone. Il significato di “grave” è collegato al fatto che un qualsiasi corpo inerte dotato di massa (un “grave” appunto) passivamente si lascia attirare dalla forza di gravità. Con l’aggettivo “severo” invece indichiamo sempre un’indole, un carattere della personalità, un modo di porsi, che è riferito o direttamente a persone (il giudice, il maestro) o all’opera della loro creatività (un edificio, un brano musicale) nella quale l’autore ha attivamente e consapevolmente impresso il proprio marchio distintivo.
L’uso di “severo” al posto di “grave” riflette probabilmente l’abitudine a tradurre testi inglesi in modo piatto, sostituendo pedissequamente ad ogni parola del testo originale quella che più le assomiglia in italiano, senza tener conto di una regola fondamentale della buona traduzione, quella secondo cui il testo tradotto dovrebbe apparire in tutto e per tutto come se fosse stato concepito originariamente nella lingua di destinazione, senza portare con sé legami troppo evidenti con la lingua di partenza. Indipendentemente dalle cause, comunque, le conseguenze immediate di un simile uso dei termini consistono in un appiattimento delle possibilità espressive della lingua, fatto che non va visto certamente come evoluzione della lingua stessa, ma al contrario come involuzione.
Per chiarire che si tratta di una questione seria e per nulla oziosa, vorrei ora, ragionando sul lungo termine, esaminare più nel dettaglio un’altra possibile conseguenza del trasferimento delle accezioni negative di “grave” a ciò che propriamente viene detto “severo”. Partendo dal presupposto che un giudice o un maestro quando esprimono severità stanno compiendo nel modo corretto il loro lavoro e stanno onorando l’istituzione che rappresentano, il fatto che nella lingua italiana si faccia strada un’accezione di “severo” che riporta a traumi, sangue, malattia e morte può portare ad una generale diffidenza e un’ingiusta discriminazione verso queste figure. Un simile giudice potrebbe essere con maggiore frequenza rispetto ai colleghi oggetto di ricusazione; i genitori degli studenti potrebbero protestare o addirittura ritirare i figli dalla scuola dove insegna un tale maestro.
Essi potrebbero quindi a poco a poco essere sostituiti, per placare gli animi, da controparti molli e indulgenti. Il risultato netto sarebbe da una parte la resa del sistema giudiziario, che non infliggerebbe più pene adeguate ai colpevoli, e dall’altra l’avvilimento del sistema scolastico, che perderebbe ogni efficacia nel suo scopo fondamentale di formare le giovani generazioni. E questo non è un bene, perché siamo già sull’orlo del collasso, e non possiamo pensare che un mondo pieno di criminali a piede libero, di adulti con capacità cognitive pari a quelle di bambini di un anno e di milioni di persone completamente ignoranti sia capace di salvarsi da solo.